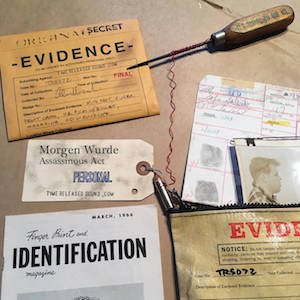ROLLING STONES
"Hackney Diamonds"
(Polydor Records, 2023)
 L’ULTIMO ROLLING STONES: OVVERO LA MITOPOIESI DEL ROCK’N’ROLL
L’ULTIMO ROLLING STONES: OVVERO LA MITOPOIESI DEL ROCK’N’ROLL
Il nuovo album dei Rolling Stones, Hackney Diamonds è andato oltre le mie aspettative ed è un portento di disco. Se consideriamo che parliamo di una band cui i membri hanno sforato l’ottantina e che ha subito il trauma della scomparsa di Charlie Watts non è poco. Mi hanno riferito che è AOR, ma dell’estetica AOR ci vedo ben poco a mio parere personale. Forse la batteria ma non più di tanto (a parte che certo AOR è tutt’altro che da buttare, vedi Journey). Anche sulla produzione di Andrew Watt qualcuno ha sollevato dubbi, ma parlando di una band come gli Stones la produzione più curata del solito ci può stare. Il precedente Blue & Lonesome era più ruvido, ma lì c’era un motivo ben preciso: quel disco è un omaggio al prewar blues e alle loro radici musicali. Questo è un fresco album di rock’n’roll. Niente è lasciato al caso. E se ci limitassimo a dire che è un disco di sano e genuino rock’n’roll? Quello immarcescibile, quello immortale, quello di cui tutti abbiamo bisogno, come diceva Lemmy. Altro che miliardari col piede nella fossa come mi è capitato di leggere tempo fa da chi è cattivo e invidioso dentro. Questa è una band che ha ancora una sana voglia di vivere e di fare musica, anziché ritirarsi a fare gli elefanti in qualche enclave di lusso aspettando la fine dei propri giorni.
Loro se ne fanno un baffo della fine dei giorni, prendono in mano il volante della vita e spingono l’acceleratore al massimo. È anche un insegnamento per chi il piede nella fossa ce l’ha prima di tutto nella testa, e potrebbe avere anche solo 20-30 anni. Questo è il sano rock’n’roll di sempre, quello che non potrà mai invecchiare perché la sua comunicativa è antica e attualissima, finché ci sarà sempre qualcuno, giovane o diversamente giovane, altra dicotomia che aborrisco, che sarà pronto a immolarsi per esso. Certo, un album come questo è rock’n’roll iconizzato, direi stigmatizzato nella sua intrinseca ontologia, ma non si può pretendere altrimenti; però iconizzato non vuol dire olografico, non è un’intonsa cartolina dei tempi andati profumata di stampa fresca, ma possiede la vitalità delle cose vive e non l’inerzia di quelle musealizzate. Credo che Hackney Diamonds sia un atto d’amore al classico rock’n’roll immortale e leggendario fatti da una band che dimostra che il concetto di invecchiare esiste solo nella mente di chi vuole essere vecchio, di chi ha preferito gettare la spugna e ritirarsi coi remi in barca a lasciarsi trasportare dalla corrente. Gli Stones la corrente non la subiscono passivamente a seconda di dove essa la portano, loro fanno partire i motori delle barche e la cavalcano, la dirigono nella direzione che vogliono darle.
 Queste sono 12 canzoni che potrebbero essere uscite dalla penna di un ventenne: ma così è infatti; l’anagrafe ha solo aggiunto un moltiplicatore che ha quadruplicato il numero 20 ma finisce tutto qui: in tutto il resto sono ragazzi di vent’anni con l’esperienza di vita di qualche primavera in più. Io trovo più vecchi e stantii parecchi album indipendenti che escono tuttora, realizzati da ventenni che non hanno idee se non copiare a macchinetta e senza alcun trasporto personale un passato che ormai non è più tanto prossimo. L’unico risultato per me è infilare una sequenza di “delete” uno dietro l’altro. Perché li trovo dei vuoti a perdere, adatti per una prassi che si chiama vivere a caso. Invece gli Stones con questo nuovo disco dimostrano che il rock’n’roll non ha età, non concepisce nemmeno l’età anagrafica, perché ipso facto è un linguaggio letterario che descrive e permea uno stile di vita. Chi scrive è un comune mortale che si è immolato in nome del rock’n’roll e quando ascolta Hackney Diamonds – e tra poco anche sul piatto dato che aspetto la mia copia in vinile – ripercorre un rito che si perpetua immutabile da anni, sempre nuovo ad ogni ascolto. Qualcuno dirà: ma non è un disco originale, è sempre il solito suono uguale e ripetuto da decenni. È vero, ma la sua forza consiste proprio in questo: nell’aver saputo rendere in maniera vibrante e potente un suono già ampiamente collaudato. Pensate che sia da tutti saperlo fare? Pensate che da una band che ha una vita artistica di sessant’anni in nome del rock’n’roll (e del rhythm&blues) si possa pretendere un lavoro alla Klaus Schulze o alla Pere Ubu? Ovviamente no, ma la forza consiste proprio nell’aver saputo rendere egregiamente questo linguaggio antico, dimostrando quanto il tempo e gli anni che passano e quanto il cosiddetto “invecchiamento” siano solo delle condizioni della mente.
Queste sono 12 canzoni che potrebbero essere uscite dalla penna di un ventenne: ma così è infatti; l’anagrafe ha solo aggiunto un moltiplicatore che ha quadruplicato il numero 20 ma finisce tutto qui: in tutto il resto sono ragazzi di vent’anni con l’esperienza di vita di qualche primavera in più. Io trovo più vecchi e stantii parecchi album indipendenti che escono tuttora, realizzati da ventenni che non hanno idee se non copiare a macchinetta e senza alcun trasporto personale un passato che ormai non è più tanto prossimo. L’unico risultato per me è infilare una sequenza di “delete” uno dietro l’altro. Perché li trovo dei vuoti a perdere, adatti per una prassi che si chiama vivere a caso. Invece gli Stones con questo nuovo disco dimostrano che il rock’n’roll non ha età, non concepisce nemmeno l’età anagrafica, perché ipso facto è un linguaggio letterario che descrive e permea uno stile di vita. Chi scrive è un comune mortale che si è immolato in nome del rock’n’roll e quando ascolta Hackney Diamonds – e tra poco anche sul piatto dato che aspetto la mia copia in vinile – ripercorre un rito che si perpetua immutabile da anni, sempre nuovo ad ogni ascolto. Qualcuno dirà: ma non è un disco originale, è sempre il solito suono uguale e ripetuto da decenni. È vero, ma la sua forza consiste proprio in questo: nell’aver saputo rendere in maniera vibrante e potente un suono già ampiamente collaudato. Pensate che sia da tutti saperlo fare? Pensate che da una band che ha una vita artistica di sessant’anni in nome del rock’n’roll (e del rhythm&blues) si possa pretendere un lavoro alla Klaus Schulze o alla Pere Ubu? Ovviamente no, ma la forza consiste proprio nell’aver saputo rendere egregiamente questo linguaggio antico, dimostrando quanto il tempo e gli anni che passano e quanto il cosiddetto “invecchiamento” siano solo delle condizioni della mente.
 Io ho una massima: si diventa vecchi solo dopo che si è passati a miglior vita. Questo solo perché chi passa a miglior vita non può più rigenerarsi perpetuamente ed è il suo ricordo che si allontana a farlo diventare vecchio. Gli Stones sono qui a dimostrarcelo: finché si è vivi non si invecchia e solo l’anagrafe aggiunge quel numero di anni in più, ma è solo matematica. Però, ascoltando queste 12 canzoni, già al primo ascolto, io sono ora al terzo, il numeratore degli anni sulle spalle si annulla e ci si abbevera ad un suono senza età, perché per assioma non conosce nemmeno il significato ontologico di età anagrafica, ma conosce invece quello filosofico di età eterna. Poi ovvio che c’è anche il realismo: lo spirito resta giovane ma il corpo invecchia. Spero che Jagger e Richards possano regalarci emozioni ancora per tanti anni, tutti lo vorremmo, ma sarebbe anche egoistico: la vita ha il suo corso e il deperimento e l’ultima fermata fanno parte della vita stessa, non possiamo nemmeno avere la presunzione di eclissarli. Ma anche quando fisicamente gli Stones non ci saranno più rimarrà un suono consegnato all’eterno nei secoli a venire. Del resto ancora oggi ascoltiamo Mozart e Beethoven. Questo disco possiede le stimmate dell’eterno, di un lessico che non potrà mai invecchiare né tantomeno morire. In fondo i Maneskin, progetto alquanto discutibile, hanno il pregio di far rivivere quel linguaggio presso le generazione dei millennials e dei post-millennials. Ma quando entrano in ballo gli Stones i Maneskin si dissolvono nell’etere e diventano antimateria, perché gli Stones incarnano l’immortalità prima ancora che la storia. La storia è una successione di eventi, un fiume che più scorre più attinge nuove acque, e, per dirla con Hegel, è l’evoluzione dello spirito del tempo. Però quando la storia entra nell’immortalità allora interviene un’entità superiore che entra in simbiosi col sentimento. Tale entità attua un processo di astrazione dalla storia stessa e le fa assumere i contorni sfumato del mito. Qual è il nome di quest’entità? Si chiama eterno, e va oltre la contingenza cronologica della storia. L’eterno è parte del mito. Gli Stones sono l’eterno e il mito, non l’astoricità ma il superamento della storia.
Io ho una massima: si diventa vecchi solo dopo che si è passati a miglior vita. Questo solo perché chi passa a miglior vita non può più rigenerarsi perpetuamente ed è il suo ricordo che si allontana a farlo diventare vecchio. Gli Stones sono qui a dimostrarcelo: finché si è vivi non si invecchia e solo l’anagrafe aggiunge quel numero di anni in più, ma è solo matematica. Però, ascoltando queste 12 canzoni, già al primo ascolto, io sono ora al terzo, il numeratore degli anni sulle spalle si annulla e ci si abbevera ad un suono senza età, perché per assioma non conosce nemmeno il significato ontologico di età anagrafica, ma conosce invece quello filosofico di età eterna. Poi ovvio che c’è anche il realismo: lo spirito resta giovane ma il corpo invecchia. Spero che Jagger e Richards possano regalarci emozioni ancora per tanti anni, tutti lo vorremmo, ma sarebbe anche egoistico: la vita ha il suo corso e il deperimento e l’ultima fermata fanno parte della vita stessa, non possiamo nemmeno avere la presunzione di eclissarli. Ma anche quando fisicamente gli Stones non ci saranno più rimarrà un suono consegnato all’eterno nei secoli a venire. Del resto ancora oggi ascoltiamo Mozart e Beethoven. Questo disco possiede le stimmate dell’eterno, di un lessico che non potrà mai invecchiare né tantomeno morire. In fondo i Maneskin, progetto alquanto discutibile, hanno il pregio di far rivivere quel linguaggio presso le generazione dei millennials e dei post-millennials. Ma quando entrano in ballo gli Stones i Maneskin si dissolvono nell’etere e diventano antimateria, perché gli Stones incarnano l’immortalità prima ancora che la storia. La storia è una successione di eventi, un fiume che più scorre più attinge nuove acque, e, per dirla con Hegel, è l’evoluzione dello spirito del tempo. Però quando la storia entra nell’immortalità allora interviene un’entità superiore che entra in simbiosi col sentimento. Tale entità attua un processo di astrazione dalla storia stessa e le fa assumere i contorni sfumato del mito. Qual è il nome di quest’entità? Si chiama eterno, e va oltre la contingenza cronologica della storia. L’eterno è parte del mito. Gli Stones sono l’eterno e il mito, non l’astoricità ma il superamento della storia.
 Con quest’album è un’elisione parlare di band storica, come lo è anche parlare di band storicizzata. Questa è una band che vive nel mito senza tempo, e il disco materiale non ha importanza se è uscito nel 2023, perché l’anno cronologico è solo un fatto puramente incidentale. Una band che vive nel mito non ha bisogno di fare i conti con un anno che è solo un numero su un calendario. Il Mito è oltre la Storia, e abbatte calendari ed età anagrafiche. Tirando le somme a un disco come questo attribuisco il termine più consono: mitopoiesi del rock’n’roll. Con mitopoiesi si intende la tendenza dell’uomo ad attribuire a fatti contingenti, alla realtà tangibile, (il rock’n’roll in questo caso) attributi mitologici astraendo dai fatti stessi: in sintesi fare poesia creando il mito, come dice la parola stessa, attingendo dal dato reale. Si estrae un evento dalla realtà e su di esso si elabora il mito. Nel caso degli Stones il fatto reale rock’n’roll non l’hanno certo vissuto di riflesso: l’hanno cavalcato e l’hanno codificato da dentro, ne sono stati demiurghi del rinnovamento, dalle radici blues e rhythm&blues, passando attraverso gli anni ’50. Però con l’avanzare dell’età anagrafica, e sottolineo anagrafica, sono arrivati al 2023 concependo un album che prende la dimensione storicizzata del rock’n’roll e la traghetta in una dimensione ulteriore che si chiama mito. Gli Stones non solo hanno riformulato il rock’n’roll dalle fondamenta ma, senza cadere nella trappola dell’olografia, sono stati capaci di creare la mitopoiesi del rock’n’roll, l’eterna poesia-mito di un linguaggio antico e attualissimo. Essi sono stati dei nuovi demiurghi in passato ed ora assurgono loro stessi al rango di letterati mitopoietici della propaganda fideistica del rock’n’roll. Quindi concludendo: è l’album di un gruppo di ventenni o di ottantenni? È un disco di eterni ventenni, il resto è solo un moltiplicatore che ha quadruplicato il dato numerico solo per una questione burocratica. È la dimostrazione che il rock’n’roll non è solo un linguaggio di popolo ma è patrimonio di popolo, riconosciuto antropologicamente e iscritto negli annali mitologici e mitopoietici.
Con quest’album è un’elisione parlare di band storica, come lo è anche parlare di band storicizzata. Questa è una band che vive nel mito senza tempo, e il disco materiale non ha importanza se è uscito nel 2023, perché l’anno cronologico è solo un fatto puramente incidentale. Una band che vive nel mito non ha bisogno di fare i conti con un anno che è solo un numero su un calendario. Il Mito è oltre la Storia, e abbatte calendari ed età anagrafiche. Tirando le somme a un disco come questo attribuisco il termine più consono: mitopoiesi del rock’n’roll. Con mitopoiesi si intende la tendenza dell’uomo ad attribuire a fatti contingenti, alla realtà tangibile, (il rock’n’roll in questo caso) attributi mitologici astraendo dai fatti stessi: in sintesi fare poesia creando il mito, come dice la parola stessa, attingendo dal dato reale. Si estrae un evento dalla realtà e su di esso si elabora il mito. Nel caso degli Stones il fatto reale rock’n’roll non l’hanno certo vissuto di riflesso: l’hanno cavalcato e l’hanno codificato da dentro, ne sono stati demiurghi del rinnovamento, dalle radici blues e rhythm&blues, passando attraverso gli anni ’50. Però con l’avanzare dell’età anagrafica, e sottolineo anagrafica, sono arrivati al 2023 concependo un album che prende la dimensione storicizzata del rock’n’roll e la traghetta in una dimensione ulteriore che si chiama mito. Gli Stones non solo hanno riformulato il rock’n’roll dalle fondamenta ma, senza cadere nella trappola dell’olografia, sono stati capaci di creare la mitopoiesi del rock’n’roll, l’eterna poesia-mito di un linguaggio antico e attualissimo. Essi sono stati dei nuovi demiurghi in passato ed ora assurgono loro stessi al rango di letterati mitopoietici della propaganda fideistica del rock’n’roll. Quindi concludendo: è l’album di un gruppo di ventenni o di ottantenni? È un disco di eterni ventenni, il resto è solo un moltiplicatore che ha quadruplicato il dato numerico solo per una questione burocratica. È la dimostrazione che il rock’n’roll non è solo un linguaggio di popolo ma è patrimonio di popolo, riconosciuto antropologicamente e iscritto negli annali mitologici e mitopoietici.
Le canzoni sono tutte belle. La splendida blues-ballad Sweet Sound of Heaven, ospiti Stevie Wonder e Lady Gaga, è di quelle immortali che toccano le corde nel profondo dell’anima. Angry è puro Stones-style, energica ed elettrica quanto classica (anche nel video con succinta vamp da ormoni in subbuglio). Whole Wide World è un rock radiofonico deciso e senza fronzoli. Mess It Up è distillato sixty Stones sound con un refrain di puro rhythm&blues. Live By The Sword è un rock’n’roll tirato con un Elton John che si lancia in un pianismo honky tonk-boogie New Orleans, di quelli che risvegliano lo zenzero sotto la pelle. Non mancano le ballatone: Depending On You è la prova intramontabile della potenza del rock’n’roll di imbastire romantiche loser ballad, mentre Dreamy Skies è una country ballad con una steel guitar da solarità desertiche texane, e Driving Me Too Hard è un’altra ballad elettrica e solare adatta per guidare all’ombra delle Rocky Mountains. Bite My Head Off, con Paul McCartney al basso, è pura energia rock’n’roll col pedale spinto a mille all’ora. Tell Me Straight, con Keith Richards, è una sognante song pregna di umori autunnali. Get Close è una soul-rock song in cui i proverbiali riff rollingstoniani si vestono di una romantica verve. Infine non manca l’omaggio alle radici: la ripresa della Rolling Stones Blues di Muddy Waters, il brano che diede il nome alla band, qui resa in una primordiale versione Delta blues.
Marco Fanciulli